CHI RESTAURA NOTRE-DAME DI PARIGI E’ CALABRESE
 Giocava con il computer a otto anni e “per caso” si è trovato davanti al primo lavoro di catalogazione del patrimonio artistico.
Giocava con il computer a otto anni e “per caso” si è trovato davanti al primo lavoro di catalogazione del patrimonio artistico.
Qualche volta si è “giocato” la scuola per rifugiarsi nel rudere della Chiesa di San Francesco dove erano presenti moltissimi reperti.
Voleva fare il musicista e mai l’architetto ed invece si laurea in architettura e si specializza in informatica.
Dopo il suo 110 e lode vola in Francia e diventa ricercatore, poi professore e adesso direttore di un centro di ricerca del CNR francese e coordinatore del cantiere digitale per il restauro della Cattedrale di Notre Dame.
Si tratta di Livio De Luca, calabrese determinato, ideatore di un metodo innovativo che permette di passare dal rilievo fotografico alla ricostruzione di una immagine reale.
“Vivevo in una casa moderna – dice – costruita da mio padre. Da lì potevo guardare il centro storico di Amantea e tutta la parte nuova. I miei occhi osservavano il passato ed il presente proiettato verso il futuro”.
Le sue parole racchiudono musicalità così come quando afferma che “in quella casa, si stava bene. Eravamo io, mia sorella Fabia e i miei genitori. Mia mamma a volte mi trovava a disegnare alle sei del mattino ed orgogliosa lo raccontava a tutti.”
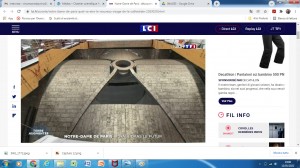 Con gli occhi carichi di emozione il professore De Luca, 46 anni, continua a parlare dei suoi affetti con profonda autenticità. “Mio padre Adriano, anch’egli architetto, per me, rappresenta l’intelligenza razionale, mia mamma Pina De Caro, quella del cuore . Una donna straordinaria che ha fatto del rapporto umano la sua stessa vita.”
Con gli occhi carichi di emozione il professore De Luca, 46 anni, continua a parlare dei suoi affetti con profonda autenticità. “Mio padre Adriano, anch’egli architetto, per me, rappresenta l’intelligenza razionale, mia mamma Pina De Caro, quella del cuore . Una donna straordinaria che ha fatto del rapporto umano la sua stessa vita.”
Ed è il padre a spingerlo a guardare lontano là dove a volte nessuno osa al pari delle aquile disegnate da Livio sui tanti fogli sparsi.
Oggi ricorda con nostalgia il suo pc commoodor 64, la sua Amantea, il fisico Fausto Perri che si interessava di catalogazione del patrimonio artistico. “Io a soli 12 anni, dice Livio, seguendo mio padre, ero lì immerso in quel mondo”.
Con il computer produceva musica elettronica da suonare nel suo gruppo “pronto soccorso band” fondato da medici.
“Ricordo con emozione Geppino Ventri che, nonostante la mia giovane età, mi ha accolto con entusiasmo”
Livio voleva fare il musicista anche perché quando stava con i suoi amici di band Eduardo Perri, Luigi Sposato, Mario Pagliaro, Vincenzo Macaione, Gianluca Garritano si sentiva carico di felicità. “Ricordarli - prosegue – mi fa un effetto straordinario”.
 Il tempo passa. Livio si iscrive al liceo scientifico di Amantea per poi concludere a Paola. I primi che qui incontra sono Dario ed Alessandro Brunori, il cantante con il quale è amico.
Il tempo passa. Livio si iscrive al liceo scientifico di Amantea per poi concludere a Paola. I primi che qui incontra sono Dario ed Alessandro Brunori, il cantante con il quale è amico.
Diplomato si iscrive alla facoltà di Architettura di Reggio Calabria e inizia a lavorare ad Amantea per la tipografia Calabria di Pellegrino.Si stava passando dal tradizionale al digitale e Livio era lì a guardare ancora, una volta, il passato ed il futuro.
“Ricordo con grande emozione il sig. Mario Pellegrino, prosegue, perché mi ha dato fiducia nonostante la giovane età.”
Poi la mente dell’architetto vola fra le persone che lo hanno formato: “i miei professori sono stati straordinari e di qualità.”
Alla facoltà di architettura scopre la passione per il CAD. Si laurea con il massimo dei voti e collabora con il professore Antonio Quistelli di cui è assistente. Sempre a Reggio, intorno al 1998, con il suo amico e collega Enrico Pasqua inizia uno studio sulla Chiesa di Santa Maria de Tridetti di Staiti. Il sistema ideato rappresenta il prototipo di ciò che poi lo renderà famoso. Si trattava di “mescolare” immagini reali per ricostruire virtualmente i pezzi mancanti. Nasce dunque nel “sud del sud” l’idea vincente che lo porterà dentro la Cattedrale di Notre Dame.
Dopo decide di specializzarsi e sceglie la Francia. “Tu adesso non puoi partire. Tua sorella sta per partorire”, esclamava la mamma. Nata Simona, dopo il brindisi, il giovane architetto vola in Francia dove riesce ad entrare in un laboratorio del CNRS di Marsiglia dove si sperimentava l’applicazione dell’informatica all’architettura. Era il punto di riferimento per tutta l’Europa. Da architetto si mette a studiare informatica. Una specializzazione molto dura superata brillantemente. Contemporaneamente insegna come professore a contratto a Venezia.
Concluso il dottorato tenta il suo sogno: entrare nel cnrs francese. “Le selezioni in Francia sono dure, dice, in alcune come queste se si è bocciati per la terza volta non si può più partecipare”. Ed invece Livio ce l’ha fatta ed eccolo diventare ricercatore. Il suo progetto sulla digitalizzazione del patrimonio artistico interessava al Ministero della cultura francese. La sua esperienza ultraventennale nel settore lo ha fatto diventare punto di riferimento per il Ministero. “In Francia, prosegue, lo Stato da fiducia ai giovani. In Italia no.”
Nel 2014 il ricercatore giunto dalla Calabria punta ancora in alto ed eccolo vincere il difficile concorso per direttore del Centro di Ricerca. Una grande soddisfazione diventare professore giovanissimo, avere un laboratorio con cinque sedi con 75 studiosi dove solo quattro sono francesi ed il resto tutti stranieri.
Con le proprie forze, arriva all’apice della carriera. La moglie Francesca, che ha studiato Storia e conservazione a Reggio Calabria lo sostiene così come i figli Marco 13 anni e Giulia 9 sono “intenti a correggere la pronuncia francese”. Ai nonni calabresi chiedono invii di soppressata! Poi il professore fa una confidenza: “nel congelatore teniamo sempre gli arancini messinesi inviati dall’altra nonna dall’estremo sud.”
Nel 2015 De Luca inizia uno studio sul ponte di Avignone e per questo riunisce studiosi di diverse discipline per avere maggiori informazioni su ogni elemento. Tutto veniva caricato in una banca dati e dalla sintesi emergevano realtà interessanti tanto da presentare un nuovo volto dell’opera. Fotografie, dati e sapere veniva interconnesso ed ecco come il “metodo De Luca” inizia a prendere forma.
Questa innovazione porta De Luca a ricevere dall’Accademia dell’Architettura un importante riconoscimento: la medaglia della ricerca.
Nel 2019 il suo pensiero scientifico continua ad andare oltre: cercare un modo per restituire ad una fotografia la tridimensionalità in modo partecipativo. Ed ecco il cuore della ricerca. Il professore mette in moto una piattaforma che chiama “aioli” come la ricetta della maionese dei poveri. In Cina la sperimenta attraverso uno studio di una antica tomba. I tanti divieti lo portano a scattare fotoe da queste ecco ricostruire l’opera nel suo sistema tridimensionale.
Poi nel 2019 il terribile incendio della Cattedrale di Notre Dame. Un grande patrimonio di importanza mondiale distrutto, caduto per terra ed esposto alla rovina.
Il ministero della Cultura francese chiedeva i dati e Notre Dame aveva solo rilievi manuali. Gli studi del professore calabrese ed il suo metodo ora più che mai servono. Ricostruire digitalmente la Cattedrale partendo dall’ampio materiale fotografico disponibile sembrava un sogno. Ed ecco l’urgente convocazione al Palazzo dell’Eliseo. Macron e la politica francese vogliono il suo autorevole parere.
Accolto come un capo di stato evidenzia lo scenario del terribile disastro e la bontà del metodo. Livio De Luca vive una grande emozione. L’altra forte quanto la prima quando giunge il presidente della Repubblica Mattarella. “E’ stato come se l’Italia fosse venuta a trovarmi in Francia!”
Il professore e tutta la sua equipe si mettono a studiare. All’interno della Cattedrale di Notre Dame tra le macerie e le travi ormai carbonizzate lavorano più di cento ricercatori intorno al “metodo De Luca”. Chi sul vetro, chi sul marmo, chi sul legno e in ogni altro elemento. Si tratta di oltre 20.000 reperti. Droni riprendono ogni cosa dall’altro. Fotografie vengono scattate in ogni angolo per non tralasciare neppure un centimetro di spazio. Carrelli che permettono spostamenti precisi delle strutture di rilievo perché ogni reperto verrà studiato da diversi specialisti ed ognuno porterà il proprio contributo scientifico.
Strutture a forma di mappamondo dove in molti punti sono presenti fotocamere e telecamere riprendono gli oggetti da ogni angolatura. Saranno questi ed altri fotogrammi ad entrare nel “metodo De Luca” e a ricercare tra le foto d’archivio la posizione esatta all’interno della Cattedrale.
De Luca come architetto dell’informazione riesce ad unire tutti i saperi scientifici attorno ad un modello digitale. Questo infondo è “aioli” ed attraverso la partecipazione dei diversi studiosi tutto potrà ritornare come prima, dice orgoglioso il giovane professore calabrese, il cui cantiere digitale è sempre in prima linea.
Adesso stanno lavorando circa 600 persone provenienti da oltre 50 paesi del mondo. Tutto sotto la regia di De Luca.
Alcuni dati della Cattedrale di Notre Dame, dice il professore, sono stati digitalizzati per tre anni consecutivi da uno studioso americano, il professore Andrew Tallow, morto però circa tre anni prima dell’incendio. Ma il giovane De Luca da testardo calabrese non si arrende. Contatta la moglie e riesce ad avere i documenti del cantiere scientifico divenuti l’inizio del suo cantiere digitale.
De Luca, nonostante questo archivio, continua giorno e notte il suo lavoro di elaborazione digitale teso a riportare al posto originario ogni frammento.
In poche parole, dall’archivio fotografico prima dell’incendio e da quello elaborato subito dopo, con il “metodo De Luca” sarà possibile ricollocare ogni frammento al giusto posto per far brillare come prima i tesori della cattedrale di “Notre Dame.”
L’interno per il 2024 potrebbe essere pronto mentre applausi e gratitudine andranno all’architetto calabrese, professore che resterà
Vincenzo Malacrinò
pubblicato negli speciali di Gazzetta del Sud











